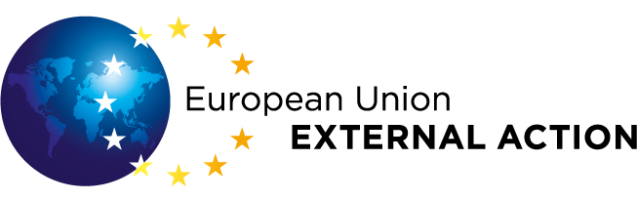Cosa difende l’Unione europea a Gaza e nel conflitto israelo-palestinese
L’Europa è circondata da una moltitudine di crisi. Sul nostro confine orientale, il fuoco della guerra arde da quasi due anni. Il popolo ucraino, sostenuto dall’Europa, sta combattendo con grande coraggio, ma la prospettiva di vittoria sulla Russia rimane lontana.
Il 7 ottobre di quest’anno è tornata la guerra in Medio Oriente. Lo spaventoso attacco terroristico di Hamas, che abbiamo immediatamente condannato con la massima fermezza, ha riacceso una spirale di violenza che a Gaza si è trasformata in una tragedia umanitaria.
Di fronte alla guerra contro l’Ucraina, l’Europa ha dato prova di unità e si è rapidamente assunta le proprie responsabilità. L’Unione ha fornito un corposo sostegno economico e militare all’Ucraina e continuerà a farlo per tutto il tempo che sarà necessario.
I due conflitti sono molto diversi per cause e attori in gioco. Tuttavia sono collegati. In particolare perché siamo sospettati di applicare tra Ucraina e Israele-Palestina due pesi e due misure sul rispetto del diritto internazionale. E questo soprattutto dai Paesi del cosiddetto «Sud globale». Dobbiamo dimostrare con le parole e con i fatti che questa accusa è infondata.
L’influenza dell’Europa nel mondo si basa principalmente sul nostro «soft power». Abbiamo un’economia sviluppata e abbiamo adottato misure per rafforzare le nostre capacità di difesa, ma non siamo ancora una vera e propria grande potenza. La nostra influenza nel mondo dipende soprattutto dalla coerenza con cui difendiamo dei valori e dei principi universali. Noi europei dobbiamo essere tra i custodi del diritto internazionale e umanitario. Ecco perché i nostri partner nel mondo – e i nostri rivali – seguono così da vicino le nostre posizioni sui drammatici sviluppi in corso in Medio Oriente.
Il conflitto a Gaza è il risultato di un fallimento politico e morale collettivo, per il quale i popoli israeliano e palestinese stanno pagando un prezzo elevato. Questo prezzo continuerà a salire se non agiamo. È il risultato dell’incapacità della comunità internazionale di risolvere la questione israelo-palestinese. Per decenni, la comunità internazionale ha formalmente sostenuto la soluzione dei due Stati, ma non è riuscita a mettere in atto la strategia concreta che l’avrebbe resa possibile.
Il cuore della questione israelo-palestinese è un problema nazionale: quello di due popoli che hanno il diritto legittimo di vivere sulla stessa terra, e che devono quindi condividerla. Trent’anni fa, all’epoca di Oslo, israeliani e palestinesi si accordarono su come condividerla. Ma questa intesa non è stata attuata. Da allora, da entrambe le parti, le forze contrarie all’accordo hanno continuato a crescere, spinte dall’orgoglio smodato di alcuni e dalla disperazione di altri.
E la violenza è aumentata. Le cifre sono spaventose, e non solo dopo l’ultimo terrificante attacco di Hamas contro Israele e la successiva risposta israeliana. Anche prima del 7 ottobre il bilancio dei morti e dei feriti era già troppo alto.
La colonizzazione illegale in Cisgiordania e la violenza contro i palestinesi sono aumentate impunemente. Dopo il 7 ottobre sono diventate ancora più brutali. Trent’anni fa c’erano 270.000 coloni in Cisgiordania. Oggi sono più di 700.000. E il territorio palestinese è stato diviso in un arcipelago di aree non collegate tra loro, cosa che rende molto più difficile l’attuazione di quella soluzione dei due Stati che la comunità internazionale chiede da 76 anni.
L’anno scorso in Cisgiordania sono stati uccisi 154 palestinesi e 20 israeliani. Quest’anno, la cifra è già salita a quasi 400 palestinesi e a una trentina di israeliani. In Palestina, la totale mancanza di prospettiva ha portato all’emarginazione delle forze moderate a favore di forze radicali animate dall’odio.
Grazie agli Accordi di Abramo, molti credevano che il problema israelo-palestinese potesse essere aggirato, anche se la situazione sul terreno continuava a deteriorarsi. Questa illusione ha contribuito ad alimentare l’odio. Da parte israeliana, con le forze estremistiche in Cisgiordania determinate a porre fine al problema palestinese attraverso la sottomissione o l’esilio. Da parte palestinese, con gli estremisti islamici che vogliono distruggere Israele e minacciare l’Occidente.
La barbarie di Hamas contro i civili israeliani il 7 ottobre è ingiustificabile e imperdonabile. È stato un attacco senza precedenti che ha provocato in Israele un profondo shock e un sentimento di paura esistenziale. Come però ha spiegato Barack Obama, «il modo in cui Israele conduce la sua lotta contro Hamas non è un dettaglio».
L’ex Segretaria di Stato americana Condoleezza Rice spiegava già nel 2011 che gli scontri a Gaza seguono uno schema prevedibile: «Hamas provoca, Israele risponde militarmente, la comunità internazionale si torce le mani». Reagendo in modo eccessivo, gli israeliani perdono il sostegno della comunità internazionale. Era già così nel 2011. Oggi, nel 2023, siamo arrivati allo stesso punto.
La strategia militare di Israele deve rispettare il diritto internazionale ed evitare, per quanto possibile, la morte e la sofferenza dei civili. Tagliare acqua, cibo, elettricità e carburante a un’intera popolazione civile sotto assedio è inaccettabile. L’entità dei bombardamenti è ugualmente estremamente preoccupante.
A breve termine, la priorità è interrompere il circolo vizioso della violenza. Non sarà facile, perché la tragedia in Israele è stata senza precedenti. Il Presidente degli Stati Uniti Biden ha invitato gli israeliani a «non farsi accecare dalla rabbia». I migliori amici di Israele non sono infatti coloro che incitano alla vendetta, ma coloro che incoraggiano la moderazione.
Secondo le autorità sanitarie di Gaza, ci sono già state oltre undicimila vittime nell’enclave, di cui quasi la metà bambini. Una strategia militare che ignora il costo umano per le popolazioni civili non funzionerà, perché rischia di rendere quasi impossibile una futura pace tra palestinesi e israeliani. È la pace l’unica vera garanzia a lungo termine per la sicurezza di Israele.
Nell’immediato, dobbiamo evitare che il conflitto si estenda all’intera regione. Con i nostri alleati americani e i nostri partner regionali, siamo costantemente in contatto con tutti gli attori in gioco per cercare di evitarlo.
Allo stesso tempo, dobbiamo lavorare per una de-escalation a Gaza e per una soluzione umanitaria. Tutti gli Stati membri dell’UE sono favorevoli a delle pause delle ostilità. Pausa umanitaria, cessate il fuoco, tregua… non importa come la si chiami, ciò che conta è limitare le sofferenze dei civili palestinesi e degli ostaggi israeliani.
Dobbiamo assicurarci che un flusso costante di aiuti umanitari entri nella Striscia di Gaza ogni giorno, in una quantità sufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione civile, carburante compreso. C’è già una carenza di cibo e la situazione è particolarmente grave negli ospedali. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 20 dei 36 ospedali di Gaza hanno smesso di funzionare a causa della mancanza di carburante, senza il quale è impossibile distribuire acqua potabile ed elettricità.
Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, da quando è stato riaperto il valico di Rafah sono entrati a Gaza in media 40 camion al giorno, circa il 20% di quelli che entravano nell’enclave prima della guerra. È necessario aumentare i volumi e aprire altri punti di passaggio. Un’altra possibilità sarebbe quella di creare un corridoio marittimo per rifornire Gaza attraverso il Mediterraneo, come proposto da Cipro. L’UE sta al momento studiando la fattibilità di questo piano.
Bisogna inoltre predisporre dei corridoi di sicurezza per l’evacuazione dei feriti, dei malati e dei cittadini stranieri, mentre il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) deve avere accesso agli ostaggi detenuti da Hamas, il cui rilascio deve essere immediato e incondizionato.
Una volta consolidata la situazione umanitaria, dovremo passare dagli aiuti umanitari alla politica. Gli sforzi dovranno concentrarsi su una soluzione a medio e lungo termine. Un piano di stabilizzazione permanente che permetta di costruire la pace tra israeliani e palestinesi e in tutta la regione.
Al Consiglio Affari esteri del 13 novembre, ho proposto ai ministri una serie di principi che dovrebbero orientare l’azione dell’UE a Gaza, principi che dobbiamo discutere con i nostri partner regionali e internazionali.
Si possono riassumere in tre «sì» e tre «no».
No alla deportazione del popolo palestinese. Non ci può essere un’espulsione dei palestinesi verso altri Paesi.
No all’amputazione del territorio di Gaza o alla sua rioccupazione da parte di Israele. Non ci può essere nessuna riduzione del territorio dell’enclave, nessun controllo permanente da parte dell’IDF e nessun ritorno di Hamas a Gaza.
No a separare la questione Gaza dalla questione palestinese. Il nostro obiettivo deve essere quello di risolvere il problema palestinese nel suo complesso.
Sì all’insediamento di un’autorità palestinese temporanea a Gaza, con un mandato e una legittimità definiti da una risoluzione unanime e inequivocabile del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e da esso garantiti. Possiamo pensare a una risoluzione rinnovabile che incoraggi le due parti a raggiungere un accordo, prima per Gaza e poi per la Cisgiordania.
Sì a un maggiore coinvolgimento degli Stati arabi, se sono d’accordo, a condizione che abbiano la fiducia sia degli israeliani sia dell’Autorità palestinese. Al momento, gli Stati arabi non sono pronti a discutere di quello che succederà il «giorno dopo». Tuttavia, se vogliamo raggiungere una soluzione duratura, avremo bisogno del loro impegno, che non potrà essere solo finanziario. Ma perché ciò avvenga, devono essere certi che la loro partecipazione non sarà fine a se stessa, ma piuttosto una tappa sulla strada che porta a uno Stato palestinese.
Infine, sì a un maggiore coinvolgimento dell’Unione europea nella regione.
Dobbiamo contribuire a costruire uno Stato palestinese pienamente sovrano, in grado di ripristinare la dignità dei palestinesi e di fare pace con Israele. Dobbiamo anche contribuire a garantire la sicurezza di Israele e della Palestina.
Dobbiamo lavorare con i nostri partner regionali per organizzare una conferenza di pace per dare attuazione alla soluzione dei due Stati. La situazione sul campo ha certamente reso questa soluzione più difficile da raggiungere oggi rispetto a trent’anni fa, ma rimane l’unica strada percorribile per portare la pace nella regione. Questo deve essere il nostro obiettivo e il nostro impegno. Altrimenti, rimarremo intrappolati in una spirale di violenza che si perpetuerà di generazione in generazione, di funerale in funerale.
Noi europei dobbiamo intensificare i nostri sforzi per promuovere la pace tra Israele e Palestina. Non solo perché è nel nostro interesse, ma anche perché è un nostro dovere morale e politico. Una parte significativa del futuro ruolo dell’Unione nel mondo, e in particolare il futuro delle nostre relazioni con molti Paesi del cosiddetto «Sud globale», dipenderà dal nostro impegno nel contribuire a risolvere questo conflitto.